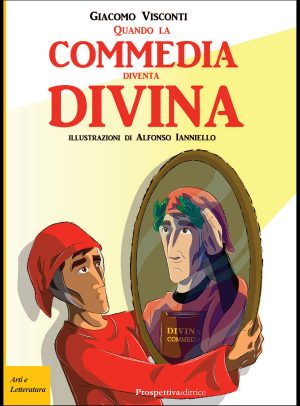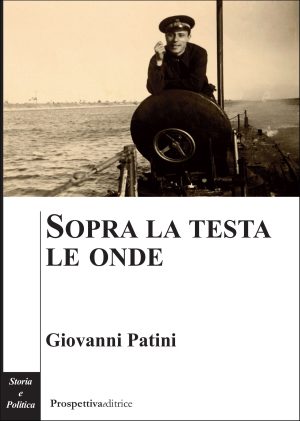UN’ALTRA VITA Il tema del doppio nel cinema muto italiano
14,00 €
Vicenzo Totaro
Costellazione Orione 120 -Arte e Cinema-| p.260 | ed. luglio 2018
- Descrizione
- Autori
- Prima pagina
Descrizione
Descrizione
Il tema del doppio, in tutte le sue forme, ha accompagnato il cinema muto italiano fino alle soglie del sonoro.
Un’altra vita analizza il tema attraverso centoquarantanove film appartenenti a generi molto diversi. Fra sogni, spettri, gemelli, sosia, ritratti e scambi di identità, il doppio dà il meglio di sé: che si tratti di capolavori o film minori, il tema mette in risalto alcune caratteristiche peculiari. Si nota un rapporto continuo con la letteratura classica, barocca e romantica. Si nota altresì una certa prossimità con il divismo cinematografico, specie di matrice femminile. Tante le dive, o aspiranti tali, che hanno affrontato il tema raddoppiando sé stesse sul grande schermo.
Quando il doppio compare nel cinema italiano porta con sé la promessa o la minaccia di un’altra vita; quella desiderata o perduta, quella che avrebbe potuto essere e non è stata, quella nascosta dalle convenzioni sociali, quella contesa al proprio sosia, quella che torna per vendicarne una stroncata troppo presto. Il doppio porta sempre con sé un’altra possibilità
Autori
Vincenzo Totaro nasce a Manfredonia nel 1981. Ha conseguito la laurea in Dams presso l’università di Bologna e successivamente la laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale, sempre presso l’ateneo bolognese. È iscritto all’AIRSC (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema). Ha lavorato per più di dieci anni come operaio addetto alla rigranulazione nel Settore Gomma-Plastica e attualmente collabora come regista e montatore presso Aelita srls, società di produzione cinematografica impegnata nella realizzazione di cortometraggi, lungometraggi e documentari.
Prima pagina
INTRODUZIONE GENERALE
Esiste una data e un film preciso con cui si indica, convenzionalmente, la nascita del cinema; il film è La sortie des usines Lumière dei fratelli Lumière e la data è il 28 Dicembre 1895, giorno in cui il film viene presentato ufficialmente per la prima volta al “Salon Indien” del Grand café, al numero 14 del Boulevard des Capucines, a Parigi. I fortunati e attoniti spettatori sono una trentina in tutto e prendono posto nel salone indiano, niente altro che un grosso seminterrato posto al di sotto del Grand café.
Esiste una data e un film preciso con cui si indica, convenzionalmente, la nascita del cinema italiano. Il film è La presa di Roma di Filoteo Alberini e la data è il 20 settembre 1905. Quella sera corrono i festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario della presa di Roma e presso Porta Pia, vale a dire sui luoghi reali degli eventi narrati nella pellicola, viene proiettato ripetutamente il primo film dell’industria cinematografica italiana, davanti a un pubblico ben più nutrito rispetto a quello che presenziò alla prima francese dieci anni addietro.
Sono date convenzionali, certamente, ma che ci raccontano qualcosa di molto interessante sul cinema italiano; nata con dieci anni di ritardo rispetto alle altre cinematografie più importanti, l’industria cinematografica italiana fa subito le cose in grande:
Il primo film di ‘manifattura’ italiana poteva vantare caratteristiche di eccellenza che lo ponevano ai vertici della migliore produzione europea: soggetto di grande levatura, complessità strutturale, alternanza tra esterni e interni, scene di massa delle comparse, attori professionisti, sicura qualità scenografica e tecnica […] Ma la particolarità tecnica che più impressionava […] era l’elevato metraggio: il film misurava ben 250 metri […] un vero e proprio colossal.
Il cinema italiano dunque, o meglio l’industria cinematografica italiana, nasce già grande ma con dieci anni di ritardo; quelli persi sono gli anni delle sperimentazioni, delle immagini malferme e degli infiniti problemi tecnici da superare. Sono gli anni delle riprese dal vero dei Lumière e del cinema fantastico di Méliès. Sono gli anni del cinema ambulante che attraversa tutta l’Europa, anche l’Italia, e che nasce come iniziativa di alcuni operatori Lumiére.
Sono gli anni del cinema delle attrazioni, di quel cinema che richiama una certa attenzione soprattutto in virtù del suo essere una novità scientifica e sensazionale e non certo per le sue qualità artistiche.
L’Italia, quindi, in questa prima fase, ha contribuito debolmente.
L’arretratezza industriale e l’endemica mancanza di capitali da investire non danno la possibilità, alla nostra cinematografia, di partecipare al miglioramento tecnologico necessario per rendere lo spettacolo cinematografico un qualcosa di più stabile e definito rispetto a quel che è nella percezione comune, e cioè un’invenzione scientifica buona soltanto per fare un po’ di soldi tra il popolino nelle fiere di paese. Prima del 1905 l’Italia può vantare il solo Kinetografo di Filoteo Alberini, regolarmente brevettato, ma con scarso successo commerciale.