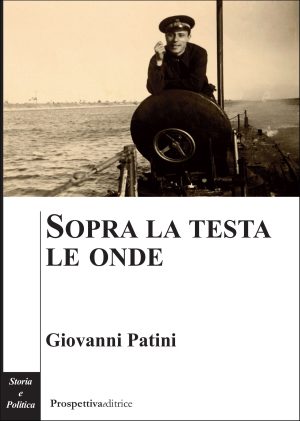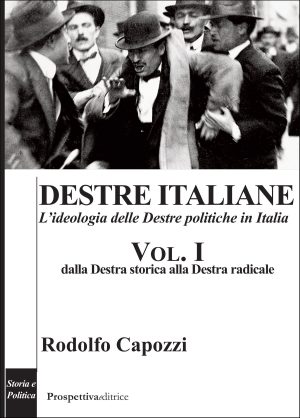NUCLEARE EAMBIENTE Il caso Italia (prevendita)
13,00 €
Danilo Persicani
Costellazione Orione 162 | ed. febbraio 2023 | p.96
- Descrizione
- Autori
- Prima pagina
Descrizione
Descrizione
LIBRO IN PREVENDITA
L’esigenza di una difesa concreta e complessiva del nostro pianeta, dovuta a trasformazioni ambientali sempre più accentuate e diffuse, ci impone di adottare nuove strategie anche sul piano
energetico.
Purtroppo, lo scontro sempre più marcato tra la visione ecologica e quella economica rischia di aggravare la situazione senza che la politica riesca, in qualche modo, a trovare un equilibrio accettabile tra le contrapposte ideologie.
Ecco allora che la scienza deve proporsi come strumento fondamentale per il superamento di tale dicotomia attraverso lo studio approfondito dell’ecosistema terrestre esaminato nell’ottica
degli inevitabili impatti prodotti dal suo sfruttamento energetico.
Autori
Danilo Persicani nasce a Piacenza nel 1953. Geologo, ricercatore e docente, durante la sua attività presso l’Università Cattolica del S.C. di Piacenza e il Politecnico di Torino pubblica numerosi articoli scientifici sul tema dell’inquinamento ambientale di acqua e suolo con particolare riferimento all’impatto prodotto dalle ricadute radioattive; egli è inoltre autore del testo universitario “Elementi di scienza del suolo” (Milano, 1989).
Prima pagina
Introduzione
La scelta europea di definire il nucleare un approccio energetico green, per la mancanza di emissioni di CO2, ha certamente creato un notevole interesse mediatico, ma anche una comprensibile preoccupazione in molti cittadini italiani che, con i risultati dei referendum del 1987 e del 2011, ritenevano di aver messo una pietra tombale su questo spinoso argomento.
Devo dire, in apertura di questo scritto, che io ho vissuto in prima persona quel periodo, sia come componente di quella società civile, sia come attore di quella parte scientifica che a
vario titolo si è occupata della ricerca in campo ambientale.
Non vi è dubbio che alcune, o forse molte interpretazioni che andrò ad esporre saranno condizionate da una parte del mio vissuto personale, ma l’intento primario di scrivere queste
modeste righe nasce e si consolida all’interno della mia esperienza professionale di geologo e ricercatore in uno specifico e ristretto contesto di valutazione ambientale che, per oltre
vent’anni, è stato dedicato all’applicazione territoriale della modellazione matematica dell’inquinamento del suolo. L’incidente prodottosi il 26 aprile del 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl ha indubbiamente segnato un’epoca fondamentale per la popolazione europea, con le conseguenti preoccupazioni di natura, prima sanitaria, e dopo ambientale, preoccupazioni e riflessioni che ovviamente risultarono amplificate per chi viveva nell’areale prossimo alla centrale nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza.
Per quanto mi riguarda, proprio in quegli anni ero aggregato ad un gruppo di ricercatori guidati dal prof. Sandro Silva, direttore del Laboratorio di Radioisotopi dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza e, come si può ben capire, quel tragico evento di portata storica diede origine a un’enorme accentuazione della mia attività di studio e di ricerca svolta anche
direttamente in campo con successivi argomenti di collaborazione con il prof. Massimo Civita del Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino e con il prof.
Masami Fukui del Research Reactor Institute of Kyoto University.
Questo richiamo, lungi dal voler essere a tutti i costi autoreferenziale, è comunque necessario per comprendere esattamente secondo quale angolatura deve essere letto questo libro che,
partendo da un’analisi obbligatoriamente sociale, si spinge molto oltre, fino a produrre qualche elemento di valutazione più strettamente scientifica. Su questo punto, però, vorrei fin da
subito chiarire che il tradizionale approccio geologico finalizzato quasi esclusivamente a esaminare il problema del nucleare secondo l’ottica della stabilità sismica del sito su cui sorgono
l’impianto di produzione energetica e il deposito dei relativi rifiuti di varia categoria, nella fattispecie sarà invece sostituito da un approccio più di superficie, dove gli elementi di analisi
non sono geofisici, ma più geochimici, pedologici e idrologici.
In altri termini, il lettore, non necessariamente dotato di specifiche conoscenze scientifiche, deve riflettere su quali possono essere i problemi (e le relative ipotetiche soluzioni) che non
riguardano la gestione dell’evento catastrofico oltremodo devastante e arealmente limitato, ma molto diversamente deve cercare di approfondire quelle realtà ambientali più ampie anche
dal punto di vista territoriale che possono riguardare estesamente e frequentemente la vita nel quotidiano, non soltanto sotto il profilo sanitario, ma anche delle infrastrutture e degli
investimenti che dovrebbero garantirci una qualità di vita sempre migliore.
Quello appena citato è stato l’inquadramento scientifico che ha caratterizzato quei numerosi progetti di ricerca a cui facevo prima riferimento e che forse oggi, con un’accresciuta sensibilità ecologica di sistema, potrebbe essere utile rivalutare rispetto alle difficilissime scelte sociali e politiche che la gravissima contingenza energetica (e bellica) ci impone di considerare, sia
nell’ottica del breve che del lungo periodo. Dobbiamo accettare, cioè, che nel corso di questi ultimi tre decenni vi sia stato un certo e comprensibile allentamento dell’attenzione nazionale
verso la tematica in oggetto, constatazione fondamentale che mi spinge ad evidenziare come alcuni tratti peculiari della stessa siano comunque e comprensibilmente rimasti ancora assolutamente uguali a se stessi, sia che il potenziale impatto ambientale e sanitario sia riconducibile a problematiche interne (nuove costruzioni e localizzazioni nel territorio italiano) che, analogamente, sia riconducibile a uno sviluppo del nucleare moderno nel resto dell’Europa, con riferimento ai territori più prossimi ai nostri confini, ma anche e indifferentemente a quelli localizzati molto più lontano.
La questione dell’approvvigionamento energetico in generale è molto seria e non si risolve rifiutando aprioristicamente ogni proposta, ma al contrario analizzando in modo approfondito e
non ideologico quante più soluzioni sia possibile porre sul tavolo della discussione sociale e del confronto politico.