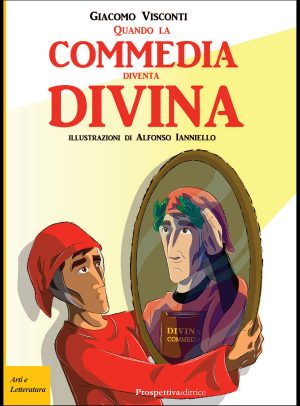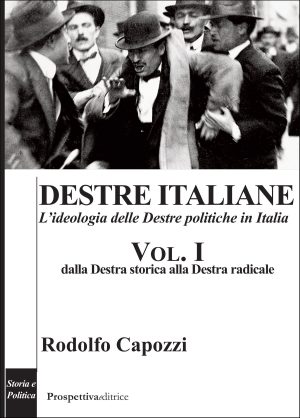Subtotale: 14,00 €
RITI E RITUALI a Napoli, in Campania e nel sud Italia
16,00 €
Giovanni Cardone
Costellazione Orione 129 – Storia e Politica – | p.402 | ed. giugno 2019
- Descrizione
- Autori
- Prima pagina
Descrizione
Descrizione
Questo libro racconta il percorso storico, antropologico ed etnologico del rito che, specialmente nel Sud Italia, si trasforma in ritualità. Noi siamo i custodi di eventi evocativi quali Leggende, Miti, Culti; in questo libro sono tutti momenti ben narrati da due grandi maestri come Ernesto De Martino e Roberto De Simone.
Con questo scritto ho voluto rivalutare la figura del grande antropologo napoletano Ernesto De Martino che ha dovuto combattere contro i grandi pensatori del suo tempo. Nella sua ricerca ha fatto emergere tutto quel linguaggio popolare, come lo descrive magnificamente Amalia Signorelli nell’intervista rilasciata a SergioTorsello nel 2005. In questo lavoro vengono analizzati, tra gli altri, il miracolo di San Gennaro, il culto mitraico e figure fondamentali della nostra cultura popolare come Pulcinella, il Vesuvio, la Sibilla Cumana, Virgilio il Mago, Raimondo di Sangro Principe di San Severo e il Cristo Velato. Ampio spazio hanno anche le varie Madonne, da quella di Piedigrotta fino ad arrivare alla Immacolata, festeggiata a Torre del Greco. Non sono stati trascurati nemmeno il culto solstiziale di San Giovanni Battista, la Tammurriata e ll linguaggio della Taranta descritta sempre De Martino. Non ho voluto dimenticare la Sicilia raccontando il Culto di Santa Rosalia, Sant’Agata e Santa Lucia e i Misteri di Trapani.
“Riti e Rituali” vuole avere l’ambizione di raccontare un percorso storico –antropologico con elementi di ricerca nuovi ma nel contempo non diversi da quella che è la nostra Tradizione, senza dimenticare le sue origini popolari che sono alla base della nostra cultura millenaria.
Autori
Giovanni Cardone Saggista, storico dell’arte e critico d’arte , docente di Storia dell’ Arte Moderna e Contemporanea presso istituzioni accademiche , universitarie e di alta formazione. Ha diretto importanti gallerie pubbliche di arte contemporanea ed ha svolto attività di ricerca e di studio in contesti accademici ed in istituzioni universitarie e di alta formazione . Nel 2014 diviene Accademico Onorario Università Svizzera Italiana mentre nel 2015 gli viene conferita la Laurea Honoris Causa in Storia dell’Arte presso l’Università Svizzera Italiana.
Prima pagina
Riti e Rituali
di Rosario Pinto
Gli studi di antropologia così come quelli di etnografia sono patrimonio di una ricerca scientifica relativamente recente, sostanzialmente riconducibile alla temperie positivista, e si rivelano articolati secondo
un interesse specifico che si volge a considerare l’uomo non nella individualità psicologica soggettiva, ma nella misura di un suo dato complessivo riferibile ad un più ampio concetto di appartenenza ad una collettività.
La pretesa di asetticità che appartiene alla metodologia positivista consiglia l’azzeramento del coinvolgimento personale e suggerisce di trasformare il soggetto umano in un numero – o, meglio ancora, in una sequenza di numeri – così da avere l’opportunità di fornire un quadro statistico entro i cui parametri è possibile restringere un processo storico e ‘leggere’ la profilatura generale di un periodo o di un gruppo umano.
Ed effettivamente, il metodo statistico ha consentito di avere una conoscenza molto ampia e molto dilatata di molti fenomeni sociali, consigliando ai governanti misure di intervento correttivo o di indirizzo propositivo opportunamente informate. Ma ha prodotto, tale metodologia d’intervento, anche l’effetto ‘collaterale’ di deprivare questa enorme messe di dati, che si è venuta a creare, di quel fremito sottile che è proprio dell’umanità, delle sensibilità individuali, delle attese, delle speranze del soggetto umano.
L’uomo ridotto a numero, considerato nella prospettiva anonima di una scansione ordinatrice di sequenze individuali di cui nessuno si preoccupa di scoprire il dettaglio, la cifra distintiva, le peculiarità soggettive, questo uomo è l’uomo-massa su cui si è scaricato tutto il peso di un modello di sviluppo che ha incentrato sul profitto tratto dalle attività produttive il nucleo centrale del suo successo, dai tempi della svolta napoleonica, passando per l’età di Luigi Filippo e giungendo, infine, alla grande guerra del 1870 che costituisce il prodromo inquietante dei grandi disastri bellici del ventesimo secolo.
La montante positivista, che, in sé non costituiva un pregiudizio insormontabile per una concezione ‘umanistica’ della storia – anzi, prometteva di poter ottenere l’ampliamento dell’accesso sociale ai benefici delle ricerche scientifiche e delle ricadute tecnologiche, come avviene, ad esempio, secondo la prospettiva anche di ordine estetico, che ne suggerisce Taine – tale montante positivista, dicevamo, mostra di essere incapace, però, a trasformare in effettiva azione riformatrice l’ansito innovatore che la pervade.
La linea dell’utopia socialista cercherà di dare un indirizzo alla costruzione di nuovi equilibri, mentre la via ‘scientifica’ al Socialismo proporrà uno strumento d’intervento, tutt’altro che riformatore e, piuttosto, propriamente rivoluzionario.
La scienza, insomma, nella prospettiva di studio positivista, produce, non secondo una necessità causale, ma sicuramente per contiguità dei tempi, un quadro storico che vede la politica ‘armarsi’ di nuovi strumenti di azione che mirano a scardinare gli assetti sociali ormai consolidati del predominio borghese.
La cultura popolare, che fino ad allora era stata ritenuta trascurabile e subalterna, comincia, pertanto, ad attrarre inediti interessi di studio e diventa tanto più interessante approfondire le ragioni delle comunità sociali perché la scienza addita con sempre più convinta consapevolezza che all’interno di tali prospettive si annidano ulteriori opportunità di ricerca che possono valere a fornire una profilatura sempre più attenta e puntuale nella descrizione dei fenomeni sociali e nell’additamento di quelli che si proporranno, poi, come processi di ‘flusso’.
Giovanni Cardone, raffinato intellettuale e conoscitore della profilatura storica del corso delle arti visive, si rivolge al mondo della cultura popolare con lo spirito giusto di un raccoglitore di memorie che non devono valere come scavo archeologico nei meandri della ancestralità umana, ma come strumento di conoscenza del nostro presente, come conoscenza, cioè, che possa liberare la nostra coscienza dai fantasmi di una cultura tecnologica che tende a sterilizzare, ad esempio, il portato prezioso della memoria. Conoscere per ricordare, potremmo sintetizzare così lo spirito che pervade l’opera di Giovanni Cardone che si volge a fornire una profilatura delle vicende di una cultura popolare che mostra, molto spesso, di avere radicamenti profondissimi e lontani, affondati nel tempo.
Un lavoro, quello di Cardone, che si iscrive nella scia dei grandi iniziatori di questi studi: pensiamo a Pitré, ma pensiamo, soprattutto, a De Martino, di cui Cardone mette a fuoco lo spessore di quella che potremmo definire una ‘venerata memoria’, seguendo il corso, peraltro, del pensiero di Amalia Signorelli che è stata profondissima conoscitrice di questo grande antropologo.
Cardone, però, non sceglie di procedere ad una raccolta museografica delle prospettazioni documentarie che la storia va man mano sedimentando: in questo egli si differenzia da quella prospettiva di ‘cultura materiale’ che ispira il disegno scientifico e ‘museografico’ di Pitré ed anche da quella sorta di ‘museificazione della memoria’ che emerge in scrittori come Gesualdo Bufalino del Museo d’ombre o come Edgar Lee Masters dell’Antologia di Spoon River.
Lo spirito che pervade la ricerca di Giovanni Cardone è, piuttosto, ancora quello di ispirazione propriamente e fertilmente positivistica, poco propenso allo sconfinamento psicologico individuale ed alla messa a fuoco, invece, di aspetti umani più larghi e pervasivi, legati ad una visione primitiva e comunitaria, ove non siamo ancora, evidentemente, ad una concezione dell’uomo-massa, ma in cui non è nemmeno immaginabile un’articolazione della vita che non si svolga all’insegna della più irriducibile interdipendenza.
Ed è a questo punto che Cardone mette a fuoco tutte le opportunità cui poteva dischiudere il cammino la scelta metodologica di De Martino e prefigura un modello di indagine che sappia valorizzare il contributo nascente da una cultura popolare che conserva riti e modalità di vita che affondano le proprie radici nel più lontano passato.
Il rito si rivela alla coscienza indagatrice di Giovanni Cardone come un grimaldello d’accesso alle ragioni identitarie più profonde della società: il rito non è, insomma, semplicemente una processualità fine a se stessa, ma è una procedura che intende conseguire un adeguamento, l’adeguamento della comunità al suo sentire profondo, fornendo uno specchiamento sociale che garantisce di una stabilità rassicurante di un modello di vita e, nella fattispecie, della ricorrenza periodica di occasioni e di opportunità.
Possiamo anche dire, in più accorta valutazione, che ciò che emerge dalla prospettiva che Cardone fornisce del rapporto tra ‘rito’ e ‘ritualità’ è la capacità del ‘rito’ di proporsi come condizione di stabilità culturale opportunamente prescritta e normata, entro cui l’espressione manifestativa della protocollarità propria della ‘ritualità’ disegna e profila un alveo di certezze consolidate per la collettività, legando gesti e procedure alla ricorrenza nel tempo che le acquisisce e le ripropone secondo la cadenza costante di una ripetizione abitudinaria.
Così le feste solstiziali, ad esempio, legate al ciclo di maturazione dei prodotti della terra, così le feste propiziatorie, per giustificare la guarigione dal male e per stabilire in un modello di continuità protocollari l’ancoraggio ad una serenità ripetitiva dei ritmi propri della vita comunitaria. Un dato importantissimo, a nostro giudizio, è quello che Cardone fornisce mettendo in rilievo l’importanza della magia, che viene pian piano presentandosi non come una alternativa ad una prospettiva escatologica e finalistica – queste cose rimangono patrimonio della religione ufficiale – ma come una capacità individuale di cogliere il senso riposto delle cose.
C’è un non detto in modo esplicito nelle parole di Cardone, ma certamente se ne colgono gli accenti nella argomentazione complessiva del suo percorso di ricerca, quando l’Autore, infatti, delinea in filigrana le ragioni per cui la religione ufficiale tollera che si pratichino ancora – sia pure con i necessari aggiustamenti dettati dall’osservanza delle indicazioni teologiche – alcune manifestazioni rituali decisamente d’ordine pagano, riconoscendo a tali comportamenti di saper cogliere il valore di una umanità profonda e la pregnanza degli affetti.